
Dr. Alessandro Cerutti - Studio di psicologia, psicodiagnosi e psicoterapia a Torino

Studio Cerutti
Studio di psicologia, psicodiagnosi e psicoterapia
Torino Via A. Fontanesi 26 bis
Contatti: tel 333 7185126
Mind in progress

A cosa servono i giorni infelici
Ci sono molti modi di vivere il dolore psicologico. Qualcuno lo vive con vergogna, come qualcosa da nascondere perchè fa sentire vulnerabili e deboli. Altri lo espongono molto, anche per sentirlo di meno. Qualcuno lo vive come una colpa da espiare, come se fosse meritato. Qualcuno lo vive dunque come una punizione. Altri lo vivono con rabbia, qualcosa che indurisce o rende in qualche modo più forti. A volte il dolore abbruttisce, svilisce il senso dell'esistenza, rende sfiduciati e disillusi, persino cinici. Altre volte ancora rende insicuri, fragili per tutta la vita. Altre volte impaurisce per sempre: rende impossibile poter ancora godere di momenti di benessere per paura di poterli di nuovo perdere, di illudersi e poi stare così persino peggio. Altre volte ancora per non vivere il dolore si smette di essere se stessi, ci si aliena da sé e si diventa qualcuno che non ci rappresenta. Nessuna di queste modalità è da giudicare: l'esperienza del dolore soggettivo è così unica che deve sempre essere rispettata. Ma le storie di chi ha vissuto gravi traumi ed eventi avversi insegnano che esiste un'altra possibilità di vivere il dolore psicologico, senza crollare. Così come pittori e scrittori hanno creato opere magnifiche trasformando le loro crisi esistenziali in forza creativa oppure soldati che hanno combattuto in guerra sono diventati cittadini esemplari e grandi uomini di stato, chiunque può maturare crescita interiore ed esprimere nuove risorse dopo gravi episodi sfavorevoli.
Tutto questo non avviene per caso e automaticamente: solo quando il dolore è "elaborato", compreso e ripensato in modo particolare e costruttivo - come succede durante i percorsi di psicoterapia - accade quella che noi psicologi chiamiamo "crescita post-traumatica" (Richard Tedeschi e Lawrence Calhoun, 1996). Capita allora che si riesca ad accedere ad una nuova narrazione della propria vita, ad una ridefizione delle proprie credenze e dei propri scopi, che si arrivi ad una nuova sensibilità, che si diventi emotivamente più ricchi e profondi, più umani ed empatici, che si approdi ad un benessere più sicuro, persino migliore di quello raggiunto prima della crisi. Il dolore non è servito solo per stare male, ma è stato riprocessato in modo utile, non in solitudine ma attraverso la potenza della relazione terapeutica, perché la nostra mente è relazionale. Non si tratta solo di sviluppare stati positivi della mente (benessere edonico), ma di poter trarre soddisfazione da sé anche in futuri periodi difficili che la vita potrà ancora riservare (benessere eudaimoico). La psicoterapia non rende bello il dolore, la "talking cure" non annulla ciò che è stato doloroso né aiuta soltanto ad adattarsi a vicende avverse ritornando al benessere precedente, ma dopo aver superato profondamente una vicenda dolorosa ci si ritrova cresciuti, persone più ricche e complesse, più libere ed espresse di quanto lo si fosse prima. E' questo il cambiamento che può scaturire da un profondo dolore quando non viene represso ne' soltanto sfogato, ma quando è invece elaborato con gli strumenti della psicoterapia. Così riesce dunque ad essere superato. E' questo che ci rende migliori e più realizzati: più radicati e uguali a noi stessi e più umani e unici in mezzo agli altri.
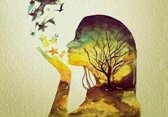
L'altra intelligenza
Quando parliamo di intelligenza intendiamo comunemente quella cognitiva. Ma a cosa serve essere intellettivamente dotati se poi siamo egocentrici, spavaldi, allontaniamo le persone con cui lavoriamo o con cui viviamo? E viceversa come possiamo esprimere le nostre capacità cognitive se siamo troppo insicuri, sospettosi o poco propensi a fidarci degli altri? Ormai da tempo la psicologia ha studiato come le prestazioni di un individuo siano determinate anche da un'altra competenza, quella emotiva, un'altra forma di intelligenza: lo ha approfondito molto bene lo psicologo statunitense D. Goleman. Siamo sicuri che sia meno determinante di quella intellettiva per raggiungere i nostri obietti e il nostro benessere?
Con intelligenza emotiva si comprende un insieme di abilità: la capacità di un individuo di essere consapevole di sé per entrare meglio in sintonia con le proprie emozioni e capire cosa può fare e da cosa invece si deve limitare, la capacità di autoregolare le emozioni evitando di indulgere agli impulsi, la capacità di motivarsi verso i propri obiettivi, la capacità di empatia per riconoscere come si sentono gli altri e trattarli nel modo migliore, infine il possesso di buone abilità sociali per comunicare in modo efficace, gestire i conflitti, saper stare nei gruppi. Queste diverse aree dell'intelligenza emotiva influenzano ad esempio la vita lavorativa e molte aziende sono ormai orientate a considerare queste variabili, in modo persino determinante, per selezionare il personale. Al di là del successo nel lavoro, prendersi cura delle proprie emozioni, conoscerle e gestirle condiziona il proprio benessere e quello degli altri, al punto da poter parlare di una vera e propria forma di intelligenza del cui potenziamento certamente si occupa la psicoterapia.
L'ultima frontiera del cervello umano è infine l'intelligenza ecologica, come spiega ancora Goleman: è la capacità di riconoscere le conseguenze di ogni nostra scelta sull'intero sistema. Considera concetti come il consumo consapevole, l'etica della produzione, il rispetto dell'ambiente, la capacità di creare network per affrontare sfide troppo complesse per una gestione individuale: in senso complessivo è l'attenzione al margine di potere - individuale e collettivo - di influire responsabilmente sulla realtà. Anche in questo caso l'intelligenza intesa come conoscenze e capacità cognitive sembra solo un dettaglio di una più ampia concezione delle facoltà umane.

Non c'è salute senza salute mentale
Mente e corpo non sono entità separate: l'organismo umano è un'unità interconnessa dove i sistemi biologici e quelli psichici sono fortemente interdipendenti. Questo implica che un'adeguata cura dei nostri stati mentali condiziona anche la nostra salute fisica e la supporta. Dalla seconda metà degli anni '80 nasce una disciplina chiamata Psiconeuroendocrinoimmunologia che, a seguito di alcune scoperte fondamentali, studia i rapporti tra la mente, il sistema neurologico, quello endocrino e quello immunitario, cioè tra i principali sistemi coinvolti nella regolazione fisiologica. Questi sistemi comunicano continuamente attraverso sostanze biochimiche: neuropeptidi, neurotrasmettitori, ormoni. Non si ammala dunque mai soltanto un organo o una funzione del corpo, ma si ammala sempre una persona. La malattia è un malessere generale e l'intervento deve essere globale, la cura richiede la partecipazione di tutto il sistema: tutto il corpo pensa e si emoziona con la nostra mente. Da tempo infatti le ricerche scientifiche hanno dimostrato come fattori soggettivi e psicosociali di persone affette ad esempio da patologie oncologiche incidano significativamente sull'aderenza alle cure e sulle complicazioni della malattia. La presenza di disturbi quali ansia e depressione e le modalità di pensiero ed emotive con cui si affronta la malattia condiziona il decorso della stessa (Leventhal et al, 2008). E' noto (Heidt et al,2004) inoltre come lo stress influenzi negativamente il sistema immunitario con inevitabili conseguenze sulla salute fisica. Una recente branca degli studi genetici, chiamata Epigenetica, studia invece i cambiamenti ereditabili nell'espressione genica che derivano da forti stress ambientali o gravi traumi emotivi: tali condizioni lasciano dei segni sul rivestimento dei cromosomi (metilazione) che alterano l'espressione funzionale dei geni in modalità trasmissibili durature e intergenerazionali. Questi studi stanno permettendo di spiegare come le influenze sociali e biologiche interagiscano nella trasmissione intergenerazionale dei traumi irrisolti, come è stato osservato dai particolari sintomi dei figli dei sopravvissuti all'Olocausto o dai bambini nati da madri coinvolte nell'attacco dell'11 settembre 2001. Sono stati anche studiati gli incubi di fatti vissuti dai genitori. I traumi non risolti possono pertanto avere un impatto sulle generazioni successive non solo per le influenze educative ma anche per alcuni cambiamenti genetici che si possono determinare, un importante segno fisico dell'impatto psicologico di un evento.
La mente ha pertanto un ruolo fondamentale nei processi di regolazione corporea: l'attenzione e la cura nei riguardi di questa influenza positivamente tutto il nostro organismo.

Chi siamo se nessuno ci guarda
Il cervello umano è biologicamente orientato, fin dalla nascita, a costruire relazioni con le figure di accudimento. Tali relazioni sono indispensabili per lo sviluppo del cervello stesso e per il benessere conseguente. Ad esempio il tono della voce della madre stimola la produzione di ossitocina, che ha un potere calmante, così come l'imprinting facciale della madre è riconosciuto molto presto ed ha un effetto benefico. Recenti ricerche hanno evidenziato come le onde cerebrali del bambino e della sua figura di accudimento si sincronizzino attraverso lo sguardo, promuovendo così lo stesso stato mentale: i bambini imparano a regolare le proprie emozioni attraverso quelle dei genitori e già nel primo anno di vita possiedono una rappresentazione di sé e del comportamento prevedibile del genitore. Si tratta di un'impronta destinata a perdurare. Viceversa, non solo gli abusi fisici e sessuali, la violenza assistita, la perdita precoce di un genitore e l'abbandono, ma anche la trascuratezza emotiva lascia un segno nella mente e nei circuiti cerebrali di un bambino.
Lo sviluppo del cervello prosegue però per tutta l'adolescenza e conserva per sempre una plasticità che permette l'assimilazione di nuove esperienze benefiche, come la psicoterapia, capace di correggere in modo mirato quelle tracce mentali e cerebrali che predispongono all'incapacità di regolare le emozioni e di costruire relazioni appaganti. Trovare le parole e poter condividere i sentimenti più profondi con un altro essere umano è una delle esperienze di risonanza più importanti che possano capitare, specialmente se altre persone nella nostra vita ci hanno ignorato o ridotto al silenzio. Ma non tutte le forme di linguaggio sono uguali. E' stato studiato come la particolare comunicazione che si sperimenta in psicoterapia attivi l'area della corteccia prefrontale mediale del cervello: questa zona permette di sentirci presenti a noi stessi, di modulare le nostre emozioni e condurci ad un migliore benessere. Come si evince dalle risonanze magnetiche e dagli studi del premio Nobel E. Kandel sulla plasticità cerebrale, la psicoterapia aumenta la forza dei circuiti neurali che connettono i lobi frontali alle zone del cervello responsabili delle emozioni, rendendoci più capaci di governarle: gli incontri ripetuti di psicoterapia cambiano il cervello. Altre esperienze, si auspica non secondarie nei programmi scolastici, possono offrire un sostegno: la musica, il teatro, l'arte e lo sport sono modalità senza tempo di migliorare la consapevolezza sensoriale, accedere alle emozioni e darvi voce, sperimentare la sintonizzazione, la condivisione emotiva e la reciprocità umana.

Nuovi adolescenti
Le trasformazioni storiche e sociali degli ultimi decenni stanno apportando notevoli cambiamenti nei processi evolutivi, nei modelli di riferimento, nella concezione della famiglia, e pertanto nel percorso di ogni adolescente. La normatività tipica dei genitori delle precedenti generazioni sta lasciando spazio ad una più complessa negoziazione della relazione: è un'opportunità che può tuttavia presentare difficoltà. Alla colpa si è sostituita la vergogna per la temuta incapacità di rispondere alle aspettative familiari e sociali, da qui il ripiego nel ritiro dal sociale e dalle responsabilità o la sovraesposizione su internet in cerca di "like". L'adolescenza "post-moderna" è così diventata un percorso sempre più personale, specifico per ogni adolescente, a volte vissuto in solitudine, Scomparse gradualmente rigide tappe e modalità socialmente definite per accedere all'età adulta, i giovani sono chiamati a coniugare - ciascuno con la propria originale combinazione - appartenenze diverse, mondi e culture differenti, relazioni e informazioni variegate. Se da una parte ai giovani contemporanei è data la possibilità di scoprire, trovare e realizzare se stessi come mai prima d'ora, il rischio può essere la dispersione della propria identità, la difficoltà di stabilizzare un nucleo soggettivo che cresca dentro la numerosità degli scambi. Il rischio opposto è la chiusura difensiva e narcisistica in se stessi o in legami di dipendenza che precludono ogni cambiamento possibile.
​Molti problemi suscitano forti preoccupazioni, ma sono superabili attraverso interventi tempestivi con il sistema familiare, con i genitori o solo con il giovane. Altri, connessi ad esempio a condotte alimentari patologiche, alla trasgressività, a comportamenti illegali o all'utilizzo di droghe possono essere trattati con interventi terapeutici più complessi. Esistono poi nuove forme di malessere dei giovani connesse ai fenomeni dell'ipertecnologia, della flessibilità e precarietà dei progetti di lavoro e dei legami amicali e sentimentali.
L'adolescenza è infine l'età che continuamente rivisitiamo ogni volta che ci troviamo di fronte a nuovi desideri, a cambiamenti importanti, a separazioni inevitabili, a paure incomprensibili e a nuove opportunità di crescita.

Modern family
L'idea di famiglia è variata continuamente nel corso della storia dell'umanità. Provando, un po' sommariamente e semplificando, a riassumere la tendenza attuale potremmo dire che oggi la cultura familiare si fonda sulla relazione e sull'affettività piuttosto che sulla normatività e sulla colpa come più tipicamente accadeva nelle generazioni precendenti. Se prima un figlio era pensato con benevolenza limitata, come un soggetto da regolamentare nei suoi aspetti pulsionali e avidi ("prima il dovere e poi il piacere!") ora - caduti grandi ideali e norme universali di riferimento - i genitori si sforzano di comprendere e assecondare l'indole del proprio figlio, di costruire una relazione di condivisione di valori, ispirati dal tentativo di rendere i figli felici piuttosto che innanzitutto obbedienti. I processi di separazione psicologica dai genitori, necessari per cercare la propria identità autentica, passano così più dalla delusione che dalla trasgressione: gestire la delusione delle aspettative condivise, specie quelle coltivate in modo grandioso durante l'infanzia in questa società che spinge al narcisismo, è il passaggio a volte doloroso ma ineludibile che sono chiamati ad affrontare i genitori degli adolescenti attuali.
Ma essere una famiglia nel nostro tempo può implicare la capacità di gestire fenomeni che introducono una grande varietà e soggettività nel costruire il legame di appartenenza: non più solo le famiglie tradizionali o quelle adottive e affidatarie, ma anche quelle ricomposte, quelle multietniche, quelle monoparentali, quelle omogenitoriali, quelle nate con i percorsi di procreazione assistita (inseminazione omologa ed eterologa) e di surrogacy. Questi mutamenti modificano l'idea di paternità e maternità, la emancipano dal genere, fanno cadere la coincidenza tra atto generativo e sessuale e quella tra affiliazione biologica e psicologica. Nel rispetto dei propri principi culturali, religiosi, personali, tutto questo fa parte della storia dei legami umani, che da sempre si trasformano e richiedono di essere accompagnati, compresi e aiutati a progettarsi in una società meno vincolata ed emotivamente più articolata.

Sesso e sentimenti nella Generazione Z
L'educazione alla sessualità e all'affettività è uno strumento per garantire la salute fisica e psicologica dei giovani, per ridurre le malattie sessualmente trasmissibili (HIV, HCV etc), prevenire le gravidanze indesiderate, gli abusi, le violenze, il bullismo e l'omofobia, ma anche per migliorare la consapevolezza della sessualità come area del potenziale umano, come espressione dell'affettività da vivere in modo appagante e allo stesso tempo responsabile. E' parte della formazione nelle scuole nella maggior parte dei paesi europei. In quelli più avanzati inizia dalla prima infanzia, a partire dalla conoscenza del proprio corpo, dal superamento di stereotipi e pregiudizi, dall'apprendimento di alcune norme sociali fondamentali ad esempio riguardo al contatto fisico, fino alla prevenzione di rischi di abuso attraverso la capacità di chiedere aiuto.
​Secondo recenti ricerche il 40% dei giovani non usa il condom, le vendite di proflilattici dal 2007 in Italia hanno registrato un calo del 16%, la propensione al testing è scarsissima. Vi sono poi fenomeni nuovi che riguardano i comportamenti sessuali, specialmente con l'intervento di internet e dei nuovi media che riguarda soprattutto la generazione dei nativi digitali cosiddetta Z (il sexting, il cyberbullismo, il grooming) e situazioni esistenziali più visibili che richiedono considerazione come i giovani gender fluid e cross gender.
Superficialmente più esibita di un tempo, la sessualità è a volte ancora un tema condizionato da preoccupazioni raccontate spesso nei colloqui di psicoterapia. E' auspicabile invece considerare la sessualità come parte dello sviluppo della personalità, della qualità della vita, della salute fisica e mentale personale e sociale.

Tempi stupefacenti
Fino agli anni Cinquanta è ancora tuttavia un fenomeno limitato ad artisti, poeti, creativi, come modalità di accesso a vissuti altrimenti inafferrabili dalla sensibilità umana. Ma dagli anni Sessanta diventa un fenomemo giovanile: da paesi esotici arrivano LSD e hashish associati a valori opposti alla società occidentale, connessi all'anticonformismo, alla ricerca di contemplazione, di lentezza e di meditazione. L'utilizzo di droghe esiste fin dai tempi antichi, come modalità per regolare il piacere e il dolore, ampliare le facoltà percettive, segnare riti significativi ed immaginare il contatto con forze soprannaturali.
Negli anni Settanta oltre a cannabis ed LSD si inizia a consumare gli oppiacei (morfina ed eroina) e la criminalità organizzata inizia a gestire il commercio e le menti dei più giovani. Aumenta la diffusione e si abbassa sempre più l'età del consumo. Con gli anni Ottanta le motivazioni sociali del consumo si invertono: la droga non è più simbolo di anticonformismo ma diventa una stampella per adattarsi meglio ad una società veloce, dinamica, consumistica e narcisistica, dove sono sempre più importanti il successo e l'affermazione personale. Sono gli anni della cocaina, la droga che aumenta il senso di potenza e poi, nel decennio successivo, delle droghe sintetiche come l'ecstasy, la droga della discoteca, della resistenza e del "supporto" per superare l'imbarazzo sociale. Si afferma sempre più la cultura della performance con l'abuso di psicofarmaci e di integratori energetici insieme ad altri fenomeni che riguardano la manipolazione del corpo, come la chirurgia plastica. L'avvento della rivoluzione digitale apre ora a nuove forme di dipendenza (cfr. Dipendenze 2.0).
La droga sollecita atteggiamenti repressivi e di condanna, anche perchè connessa al piacere e alle ambivalenze profonde che questo esercita in ciascuno. Tuttavia dietro al consumo di sostanze dei più giovani esistono bisogni e fragilità personali che devono prima essere compresi per poter essere superati, unitamente a valori e condizionamenti sociali di cui possiamo essere tutti inconsapevolmente "drogati" e "spacciatori". ​

Dipendenze 2.0
Quando si parla di dipendenza si pensa comunemente a quella da alcool o da sostanze stupefacenti. Si stanno tuttavia sviluppando e studiando nuove forme di dipendenza come le dipendenze da internet e social network. In particolare queste ultime si configurano in cinque forme:
​1) Cybersexual Addiction: uso compulsivo di siti dedicati al sesso e alla pornografia
​2) Cyber-relational Addiction: eccessivo coinvolgimento nelle relazioni nate in rete
​3) Net compulsion: comportamenti compulsivi tramite internet come gioco d'azzardo, shopping e commercio on line
​4) Information overload: ricerca di informazioni tramite la navigazione sul web
​5) Computer addiction: coinvolgimento eccessivo in giochi virtuali
Secondo recenti ricerche un ragazzo su sei passa circa cinque ore al giorno attaccato a smartphone o pc. Qualcuno usa il termine nativi digitali o persino generazione google per identidicare i giovani cresciuti in un mondo rivoluzionato e pervaso dai media digitali. Non si tratta tuttavia di coltivare posizioni mentali nostalgiche: la comunicazione e i suoi mezzi si trasformano da sempre, rispondendo al bisogno dell'uomo di esprimersi e di raggiungere i suoi scopi efficacemente. E' però importante poter capire le deviazioni patologiche, esito talvolta di bisogni mentali non riconosciuti connessi ad ansia, vuoto, noia, senso di inadeguatezza, solitudine. Bisogni che quando sono riconosciuti e accolti possono liberarsi nella relazione invece di trasformasi in comportamenti compulsivi.
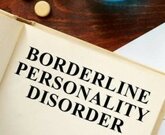
La patologia del "presente"
Ogni epoca ha il proprio modo di vivere il tempo: la nostra si fonda peculiarmente sulla dimensione temporale dell'istantaneità (cosa voglio ora) a scapito talvolta della progettualità (chi voglio diventare) e della tradizione (da dove vengo). La tecnologia, specialmente i progressi dell'informatica, ha cambiato anche il modo di vivere lo spazio, all'insegna dell'ubiquità: posso essere in contatto con chiunque e virtualmente, attraverso la rete, presente in luoghi diversi contemporaneamente.
​Questi aspetti connessi all'immediatezza dell'esperienza condizionano il modo con cui ciascuno di noi costruisce la propria identità. D.Bauman (1995) parla di identità liquida e gli psicologi, studiando i risvolti patologici di simili aspetti, parlano di personalità borderline, una configurazione psicopatologica sempre più diffusa tra i giovani e non solo, particolarmente sofferta, caratterizzata dalla ricerca della gratificazione immediata, da vissuti cronici di vuoto, incoerenza della propria identità, instabilità delle relazioni interpersonali fino a comportamenti impulsivi in aree potenzialmente dannose per sé come il denaro, il sesso, il consumo di sostanze, il cibo etc.
Se questa "sindrome della fretta" (Berman, 1982) e questo trionfo del "qui e ora" confluiscono nella configurazione borderline come espressione estrema del nostro tempo, spiegano G. Muscelli e G. Stanghellini (2014) che è in fondo la capacità di chiedersi "cosa ha a che fare questo istante con il resto delle mia vita" che permette di abitare in modo sano la nostra contemporaneità, di ritrovarsi nella velocità del nostro tempo e di riprendersi la possibilità di narrare la propria storia per poterla infine testimoniare a chi amiamo, ad un figlio, a chi la vuole ascoltare.

La salute mentale nel/del mondo
Nel mondo le persone che soffrono di disturbi mentali sono oltre 450 milioni e come conseguenza di queste patologie sono anche più esposte a sviluppare altre malattie: i costi per i governi sono molto alti e si prevede che per il 2030 l'impatto dei disturbi mentali in termini di produzione economica aumenterà significativamente: ancora troppo esigui sono gli investimenti in salute mentale. Secondo un'analisi pubblicata dalla rivista "PLoS Medicine", gli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite rischiano di fallire perchè non comprendono anche quello di migliorare la salute mentale, specie nelle nazioni più povere. Ad esempio il trattamento delle madri che soffrono di depressione è fondamentale: i figli di madri depresse hanno più probabilità di essere denutriti e di soffrire di arresto della crescita perchè mancanti delle cure fisiche e psicologiche necessarie per promuovere lo sviluppo, in alcuni paesi tali interventi riducono la mortalità infantile. Povertà e salute mentale finiscono per essere correlati: la prima è un fattore di rischio per i disturbi mentali e questi sono causa di povertà per il costo elevato dei trattamenti e la perdita di impiego. Occorre dunque investire sia direttamente in salute mentale che in interventi sociali volti a promuoverla: secondo D. Puras, inviato ONU per la Salute Mentale, "le disuguaglianze, la discriminazione e la violenza sono i maggiori fattori che alimentano le malattie mentali [...] bisogna lavorare sui diritti umani [...] una società che non favorisce l'integrazione e che non è tollerante non è normale".
​Prendendo sul serio la questione, nel 2019 la premier neozelandese Jacinda Ardern ha dedicato una significativa parte del bilancio alla salute mentale: uno psicologo per ogni ambulatorio di medicina di base, riduzione tassi crescenti di suicidio, potenziamento della lotta alle dipendenze, all’ansia e alla depressione, ma anche riduzione della povertà infantile e della violenza domestica. Considerando indicatori quali la solitudine, è stata battezzata come “finanziaria del benessere”.
La salute mentale è dunque parte del concetto globale di salute: supporta la salute fisica, la partecipazione sociale, la prosperità economica, la qualità della vita della comunità. Affrontare i grandi temi della povertà, dell'esclusione sociale e delle disuguaglianze significa infine ridurre alcuni grandi fattori di rischio per la malattia mentale. Inoltre, investire direttamente in salute mentale oltre che eticamente giusto si rivela economicamente vantaggioso: secondo una recente ricerca ogni dollaro americano investito in un trattamento mirato alle malattie mentali comuni, come depressione e ansia, porta un ritorno di 4 dollari in salute e capacità di lavoro migliori.

Innovazioni nella cura: così emdr e mindfulness sbloccano la mente
Negli ultimi anni la psicoterapia ha raggiunto evoluzioni significative che aumentano le potenzialità della cura: emdr e mindfulness sono due tra i più importanti traguardi dell'intervento psicoterapeutico. Si tratta di approcci sperimentati, perfezionati e accreditati da numerose ricerche scientifiche che ne attestano la validità.
La Mindfulness è una pratica di concentrazione che allena la mente a correggere distorsioni e interferenze, raggiungendo così stati mentali di profondo benessere. La Mindfulness origina da antiche pratiche di meditazione orientale sviluppate nel corso dell'umanità, ma successivamente filtrate degli aspetti spirituali e morali da cui sono derivate e rielaborate in protocolli clinici e procedure capaci di trasformare in modo duraturo l'esperienza della sofferenza e dello stress attraverso l'attenzione focalizzata al momento presente. E' applicata in ospedali, cliniche, centri sanitari, con il dolore cronico e la sofferenza psicologica. Uno di questi protocolli è il Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR). In età evolutiva è utilizzata in ambito preventivo ed educativo come strumento per le competenze prosociali, di tolleranza alle frustrazioni e di promozioni delle capacità cognitive. Sono stati studiati gli effetti delle pratiche di mindfulness inserite nei processi scolastici e per i bambini con disturbi dell'attenzione e iperattività. Studi nell'ambito delle neuroscienze (Siegel, 2009) ne hanno attestato l'efficacia.
​L'emdr è un metodo psicoterapeutico che rinnesca e accelera il meccanismo di autoguarigione di cui è dotato il nostro cervello così come il resto del corpo (vedi la pagina: EMDR e TRAUMA), ma che a fronte di eventi traumatici o molto stressanti viene bloccato, impedendo così di lasciare il passato nel passato.
Entrambe le metodologie valorizzano le potenzialità di cui è dotata la mente umana, integrando mente e corpo, cognizioni ed emozioni, con notevole efficacia sulla regolazione emotiva e permettendo di raggiungere utenti anche molto differenti tra loro per cultura, capacità intellettive e introspettive. Integrate se occorre nella psicoterapia tradizionale, consentono di predisporre piani terapeutici a più livelli, seguendo le necessità dell'utente. Espandere la capacità terapeutica attraverso differenti e molteplici vie di accesso al benessere, con registri diversi e anche con forme più brevi e focalizzate per iniziare, costituisce la possibilità di rendere la psicoterapia accessibile davvero a tutti.